Jidai
Takashi Miike: Ichimei
Indice articoli
 Takashi Miike: Ichimei (Death of a samurai)
Takashi Miike: Ichimei (Death of a samurai)
2011
Ebizo Ishikawa, Koji Yakusho, Eita, Hikari Mitsushima.
Takashi Miike è un autore estremamente prolifico, gira in media 6 film l'anno, che ama le tinte forti e i rifacimenti di opere del passato. Abbiamo già parlato di lui nella recensione di Sukiyaki Django, una immaginifica opera in cui vengono mescolati ingredienti tra i più diversi, come i generi western e jidai, come le citazioni nobili e quelle triviali. E torneremo sicuramente ad occuparci di lui.
Ichimei è stato presentato al Festival di Cannes nel 2011, venendo segnalato soprattutto come il primo film in concorso realizzato con tecnica tridimensionale, ma lasciando tiepida la critica e dubbioso Paolo Mereghetti - sul Corriere della Sera on line - per la eccessiva irrealistica nobiltà della trama e del linguaggio dei protagonisti. Con tutto il rispetto dovuto all'illustre critico, è proprio di una certa dignità di comportamento che si avverte la mancanza nella società moderna, mentre ne abbiamo numerosi esempi e non solo giapponesi, nelle culture di altri tempi. Che meritano quindi di essere rivisitate: che abbiamo bisogno di rivisitare.
Si tratta di un omaggio ad Harakiri, opera del 1962 di Masaki Kobayashi, che ebbe due grandi protagonisti: Tatsuya Nakadai e Rentaro Mikuni. Miike ricorre invece a Ebizo Ishikawa nei panni di Hanshiro Tsugumo, il samurai che sfida l'ordine costiuito rappresentato dall'intendente Saito, della casata di Iyi (Koji Yakusho). I costumi sono di Kazuko Kurosawa. E' la seconda opera di ambientazione storica di Miike, ma la prima, 13 assassini, anchessa rifacimento di un film degli anni 60, concedeva quasi tutto all'azione mentre qui la vicenda è molto statica, reggendosi fino alla conclusione finale quasi esclusivamente sul dialogo.
La colonna sonora di Riuichi Sakamoto concede molto allo stile musicale occidentale, mentre quella originale del 1962, di Toru Takemitsu (al suo primo serio impegno prima di divenire giustamente famoso) era di gusto tipicamente giapponese, ma non per ragioni ideologiche: l'autore trovò impossibile seguendo i canoni musicali occidentali esprimere in poche battute i sentimenti richiesti dalle azioni, che spesso concentravano i momenti topici nello spazio di pochi secondi. Riusciva altrove, al contrario, a rendere meno difficili da affrontare le scene più cruente, come nella sanguinosa rappresentazione del seppuku eseguito con una finta lama di bambu. La scena era scandita più che commentata dal triste suono del biwa, tipico strumento a corde giapponese dalle tonalità non riproducibili con analoghi strumenti occidentali.
 Potete vedere qui (con sottotitoli in spagnolo) una intervista a Masaki Kobayashi effettuata in occasione di una riedizione della sua opera originale: non tragga in inganno il dialogo, non si sta parlando del rifacimento di Takashi Miike, risalente al 2011. Kobayashi (1916-1996) era già scomparso da tempo al momento che partì il progetto di Miike.
Potete vedere qui (con sottotitoli in spagnolo) una intervista a Masaki Kobayashi effettuata in occasione di una riedizione della sua opera originale: non tragga in inganno il dialogo, non si sta parlando del rifacimento di Takashi Miike, risalente al 2011. Kobayashi (1916-1996) era già scomparso da tempo al momento che partì il progetto di Miike.
Qui lo vediamo infatti, per quanto non abbiamo informazioni sulla data cui risale l'intervista, già in tarda età e un po' affaticato: dovremmo trovarci nei primi anni 90. Si rianima di colpo quando viene affrontato l'argomento dei suoi collaboratori: erano tutti di grande livello, dagli attori allo sceneggiatore Shinobu Hashimoto, dai direttori artistici Junichi Ozumi e Shigemasa Toda al già ricordato Toru Takemitsu per le musiche: fu un caso fortunato vedere riuniti tanti talenti intorno allo stesso progetto e la carriera di tutti da quel momento decollò.
Kobayashi ricorda anche che a quei tempi di un regista si soleva chiedere se aveva uno stile "alla Mizoguchi" o piuttosto "alla Yamanaka", si era classificati automaticamente in questo o quello stilema. Ma pressoché contemporaneamente diversi direttori decisero di esplorare nuove vie espressive. Era per esempio il caso di Kurosawa, che più o meno nello stesso periodo stava girando Yoshimbo (1961) o forse Sanjuro (1962).
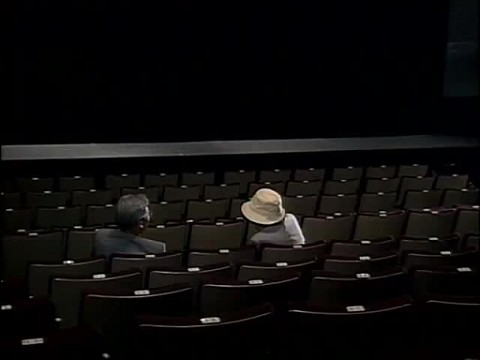 Anche Harakiri venne presentato a Cannes, e Kobayashi ricorda che ci furono diversi fischi di disapprovazione durante le scene più crude, che si convertirono però in applausi quando la magistrale interpretazione di Nakadai rese giustizia al personaggio principale e alle sue ragioni.
Anche Harakiri venne presentato a Cannes, e Kobayashi ricorda che ci furono diversi fischi di disapprovazione durante le scene più crude, che si convertirono però in applausi quando la magistrale interpretazione di Nakadai rese giustizia al personaggio principale e alle sue ragioni.
Dopo, ebbe l'impressione che gli stessi giornalisti avessero acceso una discussione tra di loro per capirne di più, mentre lui assisteva interessato e divertito.
In quanto al film, venne infine addirittura premiato.
Ricorda però anche che il suo scopo nel dirigere ogni opera era naturalmente di incontrare il favore del pubblico e della critica ma soprattutto di poter immaginare che l'uno o l'altro dei suoi mentori ed ispiratori, Keisuke Kinoshita (1912-1998) ed il poeta Yaichi Aizu (1881-1956), gli dicesse "Bravo, hai fatto un buon lavoro!".
Eppure Kinoshita si rifiutò a lungo di vedere Harakiri, turbato dalla crudezza della trama. Solo diversi anni dopo Kobayashi ebbe la soddisfazione di riceverne i complimenti.
 Crediamo con questo di avere incoraggiato la legittima curiosità del lettore, probabilmente desideroso di comprendere come mai un regista già famoso anzi sulla cresta dell'onda come Takashi Miike abbia sentito il bisogno di reinterpretare, a distanza di quasi 50 anni, questo lavoro di Masaki Kobayashi.
Crediamo con questo di avere incoraggiato la legittima curiosità del lettore, probabilmente desideroso di comprendere come mai un regista già famoso anzi sulla cresta dell'onda come Takashi Miike abbia sentito il bisogno di reinterpretare, a distanza di quasi 50 anni, questo lavoro di Masaki Kobayashi.
E' ora di passare alla recensione di Ichimei.
 L'opera è conosciuta fuori dal Giappone con il titolo Harakiri - Death of a samurai, tradotto nelle varie lingue in cui è stata distribuita. La recensione è condotta sulla versione originale sottotitolata in inglese, priva degli effetti 3d.
L'opera è conosciuta fuori dal Giappone con il titolo Harakiri - Death of a samurai, tradotto nelle varie lingue in cui è stata distribuita. La recensione è condotta sulla versione originale sottotitolata in inglese, priva degli effetti 3d.
E' abbastanza strano che nessuno dei numerosi recensori - rintracciati attraverso una ricerca veloce ma non superficiale - abbia segnalato cosa significhi il titolo originale Ichimei (一命).
Ha il significato di sopravvissuto, e certamente il protagonista, il samurai senza padrone (ronin) Hanshiro Tsugumo, è sopravvissuto suo malgrado al mondo in cui era nato e che era preparato ad affrontare. A cui da secoli venivano preparati i samurai.
Rimandiamo per la trama dettagliata alla recensione di Harakiri (titolo originario Seppuku, essendo come noto a molti la parola harakiri, più conosciuta, considerata sconveniente in Giappone). Miike non se ne discosta sostanzialmente, anche se lo spirito della sua opera ci è apparso diverso: più essenziale, più stringato, come se Miike volesse liberarsi della sua tendenza all'arricchimento, all'esasperazione dei toni. Purtroppo questo ha portato, a nostro avviso, all'affievolirsi del messaggio che l'artista intendeva trasmettere.
 Per sommi capi: alle porte della tenuta del feudo Iyi si presenta un samurai senza padrone, di nome Hanshiro Tsugumo, e chiede di parlare con il sovrintendente. Rimasto dopo la caduta del suo feudo senza alcuna possibilità di vivere dignitosamente, chiede di porre fine onorevolmente alla sua vita utilizzando il cortile d'armi degli Iyi. Pochi mesi prima si era presentato un altro samurai, Motome Chijiiwa, con una richiesta simile.
Per sommi capi: alle porte della tenuta del feudo Iyi si presenta un samurai senza padrone, di nome Hanshiro Tsugumo, e chiede di parlare con il sovrintendente. Rimasto dopo la caduta del suo feudo senza alcuna possibilità di vivere dignitosamente, chiede di porre fine onorevolmente alla sua vita utilizzando il cortile d'armi degli Iyi. Pochi mesi prima si era presentato un altro samurai, Motome Chijiiwa, con una richiesta simile.
Erano molti i guerrieri ridotti alla disperazione che giungevano a quel passo estremo, ed impietositi alcuni feudi li avevano assunti al loro servizio o almeno li avevano congedati con una somma in dono. Naturalmente questo aveva causato il dilagare del fenomeno, ed altri feudi per scoraggiarlo avevano deciso di obbligare chi inoltrasse tale richiesta a metterla immediatamente in atto. Questa era stata la sorte del giovane Chijiwa.
La catena di avvenimenti che ne segue rivela lo stretto rapporto tra Chijiwa e Tsugumo, e la fredda determinazione di questultimo deciso a dimostrare a qualunque costo la disumanità di una società ove possono accadere simili episodi, e la stoltezza della cieca obbedienza a regole prestabilite, rinunciando ad ascoltare il proprio cuore.
 Non è possibile tacere che il paragone tra le due opere è improponibile. Non solamente perché una copia non può mai essere all'altezza dell'originale, in quanto ogni artista deve tirare fuori qualcosa di esclusivamente suo al momento del gesto creativo.
Non è possibile tacere che il paragone tra le due opere è improponibile. Non solamente perché una copia non può mai essere all'altezza dell'originale, in quanto ogni artista deve tirare fuori qualcosa di esclusivamente suo al momento del gesto creativo.
Anche - forse soprattutto - perché nemmeno gli interpreti sono paragonabili. Il pur eccellente Ebizo Ishikawa XI, noto attore del teatro kabuki, riveste i panni di Hanshiro Tsugumo, vistosamente logori a rappresentare un degrado sociale e spirituale che a Tatsuya Nakadai bastava far balenare da un lampo degli occhi.
Un lampo che manca, purtroppo, negli attori delle ultime generazioni - e non stiamo parlando solamente di quelli giapponesi - o che forse il regista non è riuscito a far balenare..
Sappiamo di addentrarci su un terreno infido, ma non riteniamo estranea a questa vis espressiva dimostrata da Nakadai nel 1962 la sua educazione samurai. Ne parla lui stesso in una lunga e piacevole intervista, di cui abbiamo riportato alcune frasi nella recensione di Joiuchi (Ribellione.). Un'altra pietra miliare nel percorso artistico di Masaki Kobayashi, assieme alla grande trilogia della Condizione umana dove troviamo ancora Nakadai farsi latore del suo messaggio.
 Il ruolo del grande antagonista di Tsugumo Hanshiro, il sovrintendente Kageyu Saito che rappresenta l'autorità costituita sfidata mortalmente da un guerriero portato via dalle onde dei cambiamenti sociali, è affidato a Koji Yakusho.
Il ruolo del grande antagonista di Tsugumo Hanshiro, il sovrintendente Kageyu Saito che rappresenta l'autorità costituita sfidata mortalmente da un guerriero portato via dalle onde dei cambiamenti sociali, è affidato a Koji Yakusho.
Anche per lui il compito di confrontarsi con Rentaro Mikuni (indimenticabile interprete di L'arpa birmana) è impossibile, per quanto la sua prestazione sia comunque rimarchevole.
Miike, forse per accentuare il carattere controverso e tormentato del personaggio gli attribuisce una vistosa zoppia, che lascia intuire un suo inconfessato complesso di inferiorità nei confronti dei guerrieri ai suoi ordini ed anche dell'umile ronin che osa sfidarlo.
 Va fatto un discorso a parte per Hikokuro Omodaka, il samurai della casata di Iyi che con il suo rigido atteggiamento costringe Chijiwa ad una morte atroce. Nemmeno qui è sostenibile un paragone con Tetsuro Tamba, ma nemmeno qui ce la sentiamo di attribuirne il demerito unicamente all'interprete.
Va fatto un discorso a parte per Hikokuro Omodaka, il samurai della casata di Iyi che con il suo rigido atteggiamento costringe Chijiwa ad una morte atroce. Nemmeno qui è sostenibile un paragone con Tetsuro Tamba, ma nemmeno qui ce la sentiamo di attribuirne il demerito unicamente all'interprete.
Omodaka nella versione di Miike è solamente il villain della situazione, uno stolido personaggio completamente negativo, incapace di compiere alcun tentativo di comprendere le ragioni altrui anzi nemmeno di ammetterne l'esistenza, e la responsabilità di questa chiave di lettura va data alla sceneggiatura.
Ma in questo modo si indebolisce anche la figura di Tsugumo, che ha bisogno di un antagonista alla sua altezza: ferocemente determinato ma leale, capace di impersonare le ragioni dell'ordine costituito come lui impersona quelle della rivolta. Una figura che non può essere incarnata dall'introverso ed indeciso sovrintendente Saito.
Una ulteriore osservazione: queste immagini a confronto permettono di verificare oggettivamente l'indiscussa drammaticità che le immagini in bianco e nero riescono a esprimere. La pur rimarcabile qualità tecnica degli odierni film a colori non sembra avere ancora trovato metodi di espressione congeniali al dramma, oscillando si direbbe in maniera casuale tra le anonime e levigate atmosfere riservate alle soap opera e quelle gotiche dei film d'orrore, ugualmente troppo cariche anche se in direzioni opposte.
Tutto questo non basta però a farci giudicare negativamente Ichimei, il progetto era ambizioso ma la sfida meritava di essere accettata. Onore al merito di Miike che ha avuto questo coraggio, e la sua opera pur rimanendo priva della forza (del ki in termini giapponesi) che aveva saputo imprimervi Masaki Kobayashi, merita la visione.

